
Il secondo capitolo sulla MAFIA fa riferimento al periodo dal 1926 al 1943
dal Prefetto Mori allo sbarco degli Americani in sicilia
Con alterne vicende, la situazione descritta nel capitolo sulla mafia rurale andò avanti fino all'avvento del Fascismo.
Con il nuovo regime, divenne evidente che la funzione della mafia di concorrenza con i poteri dello stato non poteva essere tollerata da un sistema di potere che dall'esercizio assoluto del monopolio non solo della forza, ma anche del controllo sociale, traeva la sua ragion d'essere. Fu per questo che mafia e Fascismo entrarono in rotta di collisione.
Il 22 ottobre 1925 si insediò a Palermo il prefetto Cesare Mori, che sarebbe passato alla storia con il soprannome di "prefetto di ferro". I suoi metodi si rivelarono subito di estrema decisione e violenza. Leggiamone il resoconto dal volume di C. Duggan:
""L'assedio di Gangi" ebbe inizio la notte del 1 gennaio 1926 [...] Carabinieri e membri della Milizia occuparono come posti d'osservazione le cime delle colline. Nevicava abbondantemente. I banditi erano stati spinti dal freddo a tornare alle loro famiglie, e la polizia sapeva più o meno esattamente dove si trovavano. L'unico problema fu che Gangi era un paradiso per i banditi. La cittadina era costruita sul fianco di una collina ripida e molte case avevano due ingressi, uno al pianterreno e l'altro al primo piano. Vi erano anche nascondigli abilmente costruiti dietro muri, sotto i pavimenti o nei solai, ad opera di un certo "Tovanella". In queste condizioni, l'operazione ebbe un andamento più lento del previsto. Il primo bandito ad arrendersi fu Gaetano Ferrarello, un uomo alto, anziano, con una lunga barba, molto orgoglio e dotato di una certa nobiltà d'animo. Era stato latitante per trent'anni. Uscì dal nascondiglio la mattina del 2 gennaio, si avviò verso la casa del barone Li Destri, attigua alla piazza centrale, e si costituì al questore Crimi, l'uomo inviato da Mori a condurre l'operazione. [...] Ferrarello si sbagliava se pensava che a quel punto Mori avrebbe desistito. Scopo dell'azione non era semplicemente la resa dei banditi, ma anche la loro umiliazione: "Volevo dare alle popolazioni la tangibile prova della viltà della malvivenza", scrisse Mori nelle sue memorie. Non si doveva sparare: i banditi dovevano essere privati dell'onore di una resistenza armata. "La gente si aspettava che facessimo interrogatori - ingiuriassimo e agissimo con violenza - e ce ne andassimo senza aver ottenuto alcun risultato", disse Mori al diplomatico americano R. Washburn: "Ma io avevo un'idea diversa. Dissi ai miei uomini di entrare nelle case dei criminali, dormire nei loro letti, bere il loro vino, mangiarele loro galline, uccidere il loro bestiame e venderne la carne ai contadini della zona a prezzo ridotto". Fu dato ordine di prendere ostaggi: come per le operazioni successive, sembra che gli obiettivi principali siano stati donne e bambini. Che le donne siano state maltrattate, come affermarono in seguito critici di Mori, non è certo. Sarebbe stato indubbiamente conforme allo spirito, se non alla lettera dell'impresa, perché scopo della cattura di ostaggi era far leva sul senso dell'onore dell'uomo nei confronti della moglie e della famiglia: così un pizzico di durezza non sarebbe stato inopportuno".
Dunque una violenza e dei metodi che erano accettabili solo in uno stato non più democratico, dove le garanzie per i cittadini erano considerate molto meno della necessità di assicurare banditi alla giustizia. Testimonianze autorevoli, inoltre, dicono che Mori, durante l'assedio di Gangi e molte altre volte in seguito, si servì dell'intermediazione di personaggi al confine della legalità per ottenere la resa dei latitanti. Nell'assedio di Gangi una parte importante ebbe ad esempio il barone Sgadari, grosso proprietario terriero da tempo in affari con i mafiosi ed ora pronto a tradirli in cambio dell'impunità personale.
Tali metodi furono perseguiti per anni: furono fatti migliaia di arresti, senza troppe preoccupazioni se nel mucchio finivano anche molti innocenti. Si procedeva all'arresto, ed alla condanna per associazione per delinquere, sulla base di un semplice sospetto, o della cosiddetta "notorietàmafiosa". In questo modo alcune correnti all'interno del partito fascista, riuscirono a far arrestare, con accuse spesso infondate, i propri avversari politici. Una delle vittime più illustri fu Alfredo Cucco (fascista della prima ora e già segretario del partito, dell'ala radicale del Fascismo, in contrasto con i latifondisti e la vecchia nobiltà palermitana) che fu accusato e fatto incarcerare proprio da coloro i quali, nel partito, invece volevano appoggiarsi a questa classe sociale. Dopo undici processi, l'innocenza di Cucco fu provata, ma la sua carriera politica era terminata da tempo.
I metodi brutali del prefetto Mori ebbero sicuri risultati in termini militari. Il 1927 viene ancor oggi ricordato come l'anno in cui furono arrestati più mafiosi (ma forse anche più innocenti accusati di esserlo). Moltissimi altri furono costretti a fuggire, per lo più "rifugiandosi" negli Stati Uniti, andando a rimpolpare la nascente mafia italo-americana, che troverà poi, com'è noto, negli anni Trenta, una grande occasione di crescita nel proibizionismo.
A fianco di questi positivi risultati polizieschi, la lotta alla mafia condotta dal Fascismo presenta alcune notevoli pecche:
1. La lotta antimafia fu usata a volte per fini poco limpidi. Fu lo stesso Mori a riconoscere, nelle sue memorie, che "La qualifica di mafioso venne spesso usata in perfetta malafede ed in ogni campo, compreso quello politico, come mezzo per compiere vendette, per sfogare rancori, per abbattere avversari" (citato da Lupo, p. 148).
2. Il Fascismo non unì alla lotta sul piano militare, alcun intervento di tipo sociale, facendo anzi dei passi indietro, soprattutto nelle campagne, riaffidando quasi interamente il potere ai latifondisti. Ha scritto uno dei massimi storici dell'Italia contemporanea, Denis Mack Smith: "Mori era amico dei latifondisti. [...] Dal 1927 gli agrari erano di nuovo al potere, e la Sicilia ne pagò a caro prezzo la riabilitazione; e gli anni Trenta furono caratterizzati da abbandono e declino" ("Introduzione" a Duggan, p. IX). Un dato può dare l'idea di cosa significò questo nuovo ordine sociale in Sicilia: dal 1928 al 1935 le paghe agricole, secondo le statistiche ufficiali, diminuirono del 28% (Comm. Antim., p. 66).
3. I metodi brutali di Mori crearono malcontento nella popolazione, che spesso fu tentata a schierarsi dalla parte dei mafiosi, di fronte a forze di polizia che apparivano quasi come invasori stranieri, senza rispetto delle più elementari regole di legalità. Leggiamo ancora Mack Smith: "Ironicamente, l'operato di Mori potrebbe aver rafforzato proprio quella diffidenza nei confronti dello Stato che, come il governo, era stato così desideroso di vincere".
4. Alcune ricostruzioni storiche sembrano indicare che anche il Fascismo non fu immune da compromessi con la mafia. La cosa pare ormai accertata per il Fascismo delle origini (Duggan, Lupo), ma alcuni indizi vi sono per supporre che anche dopo l'azione di Mori, in alcune zone, l'alleanza del Fascismo con i latifondisti condusse ad un quieto vivere dove, in realtà, i vecchi mafiosi ebbero un qualche ruolo (Lupo).
APPUNTAMENTO A PRESTO PER LA TERZA PUNTATA.
dal Prefetto Mori allo sbarco degli Americani in sicilia
Con alterne vicende, la situazione descritta nel capitolo sulla mafia rurale andò avanti fino all'avvento del Fascismo.
Con il nuovo regime, divenne evidente che la funzione della mafia di concorrenza con i poteri dello stato non poteva essere tollerata da un sistema di potere che dall'esercizio assoluto del monopolio non solo della forza, ma anche del controllo sociale, traeva la sua ragion d'essere. Fu per questo che mafia e Fascismo entrarono in rotta di collisione.
Il 22 ottobre 1925 si insediò a Palermo il prefetto Cesare Mori, che sarebbe passato alla storia con il soprannome di "prefetto di ferro". I suoi metodi si rivelarono subito di estrema decisione e violenza. Leggiamone il resoconto dal volume di C. Duggan:
""L'assedio di Gangi" ebbe inizio la notte del 1 gennaio 1926 [...] Carabinieri e membri della Milizia occuparono come posti d'osservazione le cime delle colline. Nevicava abbondantemente. I banditi erano stati spinti dal freddo a tornare alle loro famiglie, e la polizia sapeva più o meno esattamente dove si trovavano. L'unico problema fu che Gangi era un paradiso per i banditi. La cittadina era costruita sul fianco di una collina ripida e molte case avevano due ingressi, uno al pianterreno e l'altro al primo piano. Vi erano anche nascondigli abilmente costruiti dietro muri, sotto i pavimenti o nei solai, ad opera di un certo "Tovanella". In queste condizioni, l'operazione ebbe un andamento più lento del previsto. Il primo bandito ad arrendersi fu Gaetano Ferrarello, un uomo alto, anziano, con una lunga barba, molto orgoglio e dotato di una certa nobiltà d'animo. Era stato latitante per trent'anni. Uscì dal nascondiglio la mattina del 2 gennaio, si avviò verso la casa del barone Li Destri, attigua alla piazza centrale, e si costituì al questore Crimi, l'uomo inviato da Mori a condurre l'operazione. [...] Ferrarello si sbagliava se pensava che a quel punto Mori avrebbe desistito. Scopo dell'azione non era semplicemente la resa dei banditi, ma anche la loro umiliazione: "Volevo dare alle popolazioni la tangibile prova della viltà della malvivenza", scrisse Mori nelle sue memorie. Non si doveva sparare: i banditi dovevano essere privati dell'onore di una resistenza armata. "La gente si aspettava che facessimo interrogatori - ingiuriassimo e agissimo con violenza - e ce ne andassimo senza aver ottenuto alcun risultato", disse Mori al diplomatico americano R. Washburn: "Ma io avevo un'idea diversa. Dissi ai miei uomini di entrare nelle case dei criminali, dormire nei loro letti, bere il loro vino, mangiarele loro galline, uccidere il loro bestiame e venderne la carne ai contadini della zona a prezzo ridotto". Fu dato ordine di prendere ostaggi: come per le operazioni successive, sembra che gli obiettivi principali siano stati donne e bambini. Che le donne siano state maltrattate, come affermarono in seguito critici di Mori, non è certo. Sarebbe stato indubbiamente conforme allo spirito, se non alla lettera dell'impresa, perché scopo della cattura di ostaggi era far leva sul senso dell'onore dell'uomo nei confronti della moglie e della famiglia: così un pizzico di durezza non sarebbe stato inopportuno".
Dunque una violenza e dei metodi che erano accettabili solo in uno stato non più democratico, dove le garanzie per i cittadini erano considerate molto meno della necessità di assicurare banditi alla giustizia. Testimonianze autorevoli, inoltre, dicono che Mori, durante l'assedio di Gangi e molte altre volte in seguito, si servì dell'intermediazione di personaggi al confine della legalità per ottenere la resa dei latitanti. Nell'assedio di Gangi una parte importante ebbe ad esempio il barone Sgadari, grosso proprietario terriero da tempo in affari con i mafiosi ed ora pronto a tradirli in cambio dell'impunità personale.
Tali metodi furono perseguiti per anni: furono fatti migliaia di arresti, senza troppe preoccupazioni se nel mucchio finivano anche molti innocenti. Si procedeva all'arresto, ed alla condanna per associazione per delinquere, sulla base di un semplice sospetto, o della cosiddetta "notorietàmafiosa". In questo modo alcune correnti all'interno del partito fascista, riuscirono a far arrestare, con accuse spesso infondate, i propri avversari politici. Una delle vittime più illustri fu Alfredo Cucco (fascista della prima ora e già segretario del partito, dell'ala radicale del Fascismo, in contrasto con i latifondisti e la vecchia nobiltà palermitana) che fu accusato e fatto incarcerare proprio da coloro i quali, nel partito, invece volevano appoggiarsi a questa classe sociale. Dopo undici processi, l'innocenza di Cucco fu provata, ma la sua carriera politica era terminata da tempo.
I metodi brutali del prefetto Mori ebbero sicuri risultati in termini militari. Il 1927 viene ancor oggi ricordato come l'anno in cui furono arrestati più mafiosi (ma forse anche più innocenti accusati di esserlo). Moltissimi altri furono costretti a fuggire, per lo più "rifugiandosi" negli Stati Uniti, andando a rimpolpare la nascente mafia italo-americana, che troverà poi, com'è noto, negli anni Trenta, una grande occasione di crescita nel proibizionismo.
A fianco di questi positivi risultati polizieschi, la lotta alla mafia condotta dal Fascismo presenta alcune notevoli pecche:
1. La lotta antimafia fu usata a volte per fini poco limpidi. Fu lo stesso Mori a riconoscere, nelle sue memorie, che "La qualifica di mafioso venne spesso usata in perfetta malafede ed in ogni campo, compreso quello politico, come mezzo per compiere vendette, per sfogare rancori, per abbattere avversari" (citato da Lupo, p. 148).
2. Il Fascismo non unì alla lotta sul piano militare, alcun intervento di tipo sociale, facendo anzi dei passi indietro, soprattutto nelle campagne, riaffidando quasi interamente il potere ai latifondisti. Ha scritto uno dei massimi storici dell'Italia contemporanea, Denis Mack Smith: "Mori era amico dei latifondisti. [...] Dal 1927 gli agrari erano di nuovo al potere, e la Sicilia ne pagò a caro prezzo la riabilitazione; e gli anni Trenta furono caratterizzati da abbandono e declino" ("Introduzione" a Duggan, p. IX). Un dato può dare l'idea di cosa significò questo nuovo ordine sociale in Sicilia: dal 1928 al 1935 le paghe agricole, secondo le statistiche ufficiali, diminuirono del 28% (Comm. Antim., p. 66).
3. I metodi brutali di Mori crearono malcontento nella popolazione, che spesso fu tentata a schierarsi dalla parte dei mafiosi, di fronte a forze di polizia che apparivano quasi come invasori stranieri, senza rispetto delle più elementari regole di legalità. Leggiamo ancora Mack Smith: "Ironicamente, l'operato di Mori potrebbe aver rafforzato proprio quella diffidenza nei confronti dello Stato che, come il governo, era stato così desideroso di vincere".
4. Alcune ricostruzioni storiche sembrano indicare che anche il Fascismo non fu immune da compromessi con la mafia. La cosa pare ormai accertata per il Fascismo delle origini (Duggan, Lupo), ma alcuni indizi vi sono per supporre che anche dopo l'azione di Mori, in alcune zone, l'alleanza del Fascismo con i latifondisti condusse ad un quieto vivere dove, in realtà, i vecchi mafiosi ebbero un qualche ruolo (Lupo).
APPUNTAMENTO A PRESTO PER LA TERZA PUNTATA.
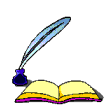
Nessun commento:
Posta un commento